Avvezzo alla scrittura musicologica e autore di vari studi sulla musica marchigiana, in particolare sul teatro, Marco Salvarani è alla sua prima prova letteraria (Marco Salvarani, Se nascono i diletti. Fantasia dorica su musica di Vivaldi, Macerata, ev casa editrice, 2025, pp. 167).
Ci consegna un romanzo breve, leggero e avvincente, tutto intessuto sulla trama della musica e immaginato nel 1738, quando fu riaperto dopo nove anni di chiusura il Teatro La Fenice di Ancona, situato nei pressi del porto e oggi scomparso, con il Siroe Re di Persia di Antonio Vivaldi, una delle ultime rappresentazioni italiane del compositore veneziano, accolta nella città dorica con vivo successo, come ebbe a scrivere lo stesso Vivaldi dopo qualche mese in una lettera a Guido Bentivoglio di Ferrara, parlando dei “mille applausi” che il lavoro ricevette.
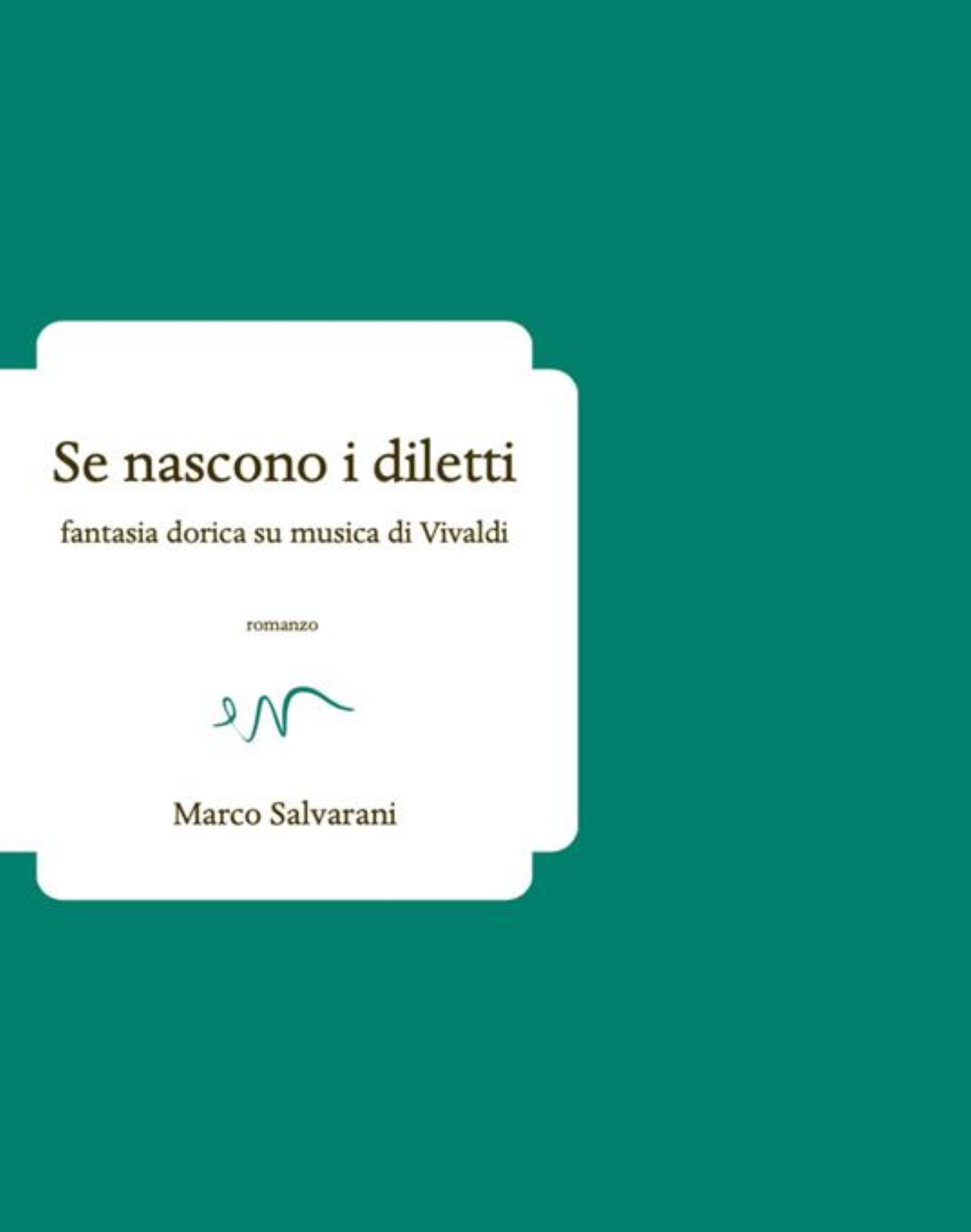
La partitura dell’opera, che era stata rappresentata per la prima volta nel 1727 a Reggio Emilia, è andata perduta ma dal raffronto dei libretti superstiti se ne deducono molte modifiche sia nel libretto che nella partitura, con una ventina di nuove sezioni tra recitativi e arie; aspetto che accende nella fantasia del romanziere (ma con il supporto di uno studioso vivaldiano come Reinhard Strohm) l’ipotesi, plausibile, che il compositore veneziano abbia trascorso ad Ancona il periodo delle prove, sorvegliando la produzione dell’opera, come era solito fare.
Il protagonista del romanzo non è però lui, ma il Conte, raffinato dilettante di musica, personaggio ispirato a più figure del patriziato locale, la cui personalità si delinea a poco a poco: uomo cupo, solitario, amante delle arti e segnato da profondi dolori familiari, il Conte è Presidente della Deputazione del Teatro, accoglie Vivaldi in arrivo via mare su una tartana proveniente da Chioggia con la sua Compagnia d’Opera, e ospita gli artisti nel proprio palazzo durante l’estate del 1738, periodo delle prove.

La permanenza ad Ancona di Vivaldi e degli artisti, tra cui diverse cantanti donne, fatto questo non comune nello Stato della Chiesa (Anna Tessieri, in arte Girò, accompagnata dalla sorella maggiore; Margherita Gualandi, in arte La Campioli, che diede fine alla carriera di cantante proprio ad Ancona, e suo marito Lorenzo Moretti; Caterina Fumagalli detta La Romanina e Elisabetta Rizzi; più il costumista e il coreografo) dà luogo ad un piacevole racconto di invenzione, sostenuto da fatti storici e occasione per divagazioni socio-politiche: i difficili rapporti tra Ancona e Venezia, il conservatorismo della Chiesa, la nascente Massoneria. Vi fanno capolino, direttamente o indirettamente, Luigi Vanvitelli, residente all’epoca ad Ancona, dove progettò il nuovo Lazzaretto e l’Arco clementino, in dotta conversazione con il compositore sui rapporti tra musica e architettura durante una cena a casa del Conte; Giuseppe Tartini, di cui viene ricordata la scoperta, nel 1713, del “terzo suono” proprio alla Fenice; Pergolesi, conosciuto a Napoli dalla Fumagalli, Montesquieu e Charles de Brosses, entrambi di passaggio nella città attorno a quegli anni.

Il racconto si condisce poi di un leggero intrigo, la minaccia di un sabotaggio ai danni della première dello spettacolo, suggerito al Conte da un uomo mascherato con una bauta veneziana: ne segue qualche momento di suspence durante la rappresentazione, descritta sia nelle note di colore relative al pubblico sia nella musica, in parte conosciuta per essere alcune arie tratte da altre opere preesistenti, in parte percorsa con l’immaginazione fino ai sentenziosi versi finali, che ispirano il titolo del romanzo: I suoi nemici affetti / di sdegno e di timor / il placido pensier / più non rammenti /. Se nascono i diletti / dal grembo del dolor / oggetto di piacer / sono i tormenti.
Tormenti e diletti si confondono quindi, in un lieto fine che sarà anche quello delle vicende biografiche del Conte, capace di superare la sua solitudine e di rinascere a nuova vita, proprio come la creatura mitologica evocata dal teatro che rappresenta.



