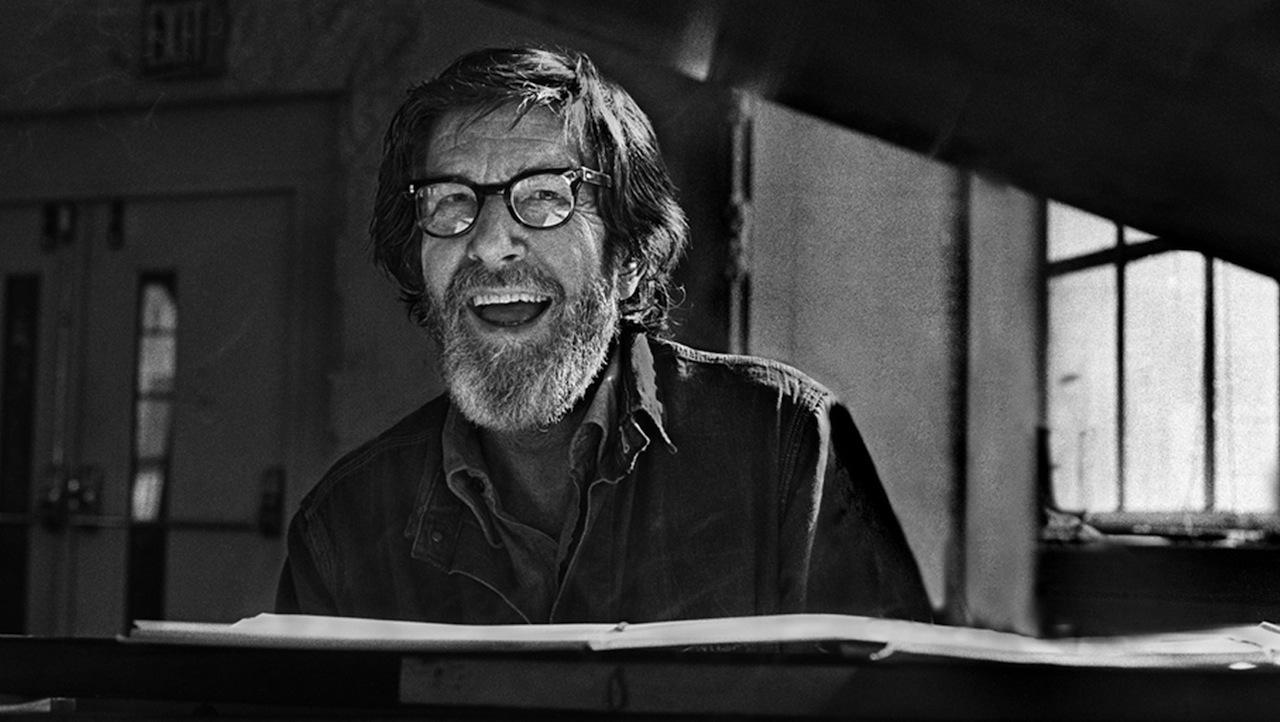Cinquecento e passa pagine che affascinano e attirano come in un gorgo ammaliante, quelle di MusiCage (il Saggiatore, 34€), libro che raccoglie una serie di conversazioni a cui John Cage fu sollecitato da Joan Retallack (che è poetessa e linguista, non musicologa) nell’ultimo periodo della sua vita.
Pagine su cui tornare, meditare, sorridere, pagine che riproducono il tono della conversazione con tutte le sue irregolarità, pagine molto cageane che forniscono allo studioso, ma anche al semplice appassionato di musica in generale, una formidabile cassetta degli attrezzi per conoscere meglio Cage.
Per parlare del libro abbiamo fatto anche noi una chiacchierata (ci sembrava coerente) e l’abbiamo fatta con il musicologo Veniero Rizzardi, che del libro ha curato la prefazione, in cui traccia un prezioso compendio della presenza e della ricezione di Cage nel nostro paese.
Come si colloca questo libro nella letteratura di e su Cage?
«Cage era un grande, piacevole conversatore, molto generoso con tutti quelli che nella parola parlata desideravano ritrovare una linearità discorsiva che nella musica sua non c’è, e nemmeno troppo nei suoi testi scritti, se non alcuni tra i primi. Nella letteratura cageana hanno dunque un notevole peso i colloqui e le interviste, anzi: diversi interi libri-intervista. Questo però ha qualcosa di speciale: sono veramente le ultime parole di Cage sulla sua musica, raccolte nel luglio 1992 a meno di un mese dalla morte. Cage è stato, fino all’ultimo, attivissimo. Nel libro si parla di una nuova notazione microtonale con cui aveva appena iniziato a sperimentare: ci sono due pagine dedicate a Stefano Scodanibbio in cui Cage descrive un pezzo che intende scrivere per lui, entusiasta dopo averlo ascoltato. Non ha fatto in tempo nemmeno ad abbozzarlo, e tra l’altro nemmeno Stefano è più con noi…».
Quali aspetti di Cage, secondo te, Joan Retallack – che, da linguista, ha subito inteso che la forma più ricca per restituire l’uomo e il musicista fosse la conversazione più che una vera e propria intervista – riesce a portare alla luce in queste pagine che magari erano emersi in modo minore altrove?
«MusiCage si potrebbe definire un audiolibro in forma scritta, per come restituisce il parlato in tutte le sue sfumature, incertezze, cambi di rotta, intercalari, frequentissime risate, ma anche l’ambiente domestico, gente che va e che viene, “prendiamoci un tè e spegniamo un momento il registratore”, persino il soundscape (figurarsi) dell’appartamento, con il rumore prodotto dall’assistente di Cage che sta riparando una libreria… E questa è una scelta portata avanti con rigore sistematico. La curatrice, poi, non si occupa professionalmente di musica, ma è poeta, linguista, femminista, e incontra Cage su un piano di conversazione più libero e spazioso di quello solitamente intavolato da musicologi e critici. Un altro prodotto notevole dell’impostazione di Retallack è che la sua adesione simpatetica al pensiero dell’artista non produce quell’effetto di cristallizzazione feticistica che tanto spesso si è incontrato nella letteratura cageana. Inoltre la sua amicizia con Cage si legge in un’evidente complicità tra i due, ma è una complicità che invita, e non esclude, il lettore. Nonostante il taglio spesso filosofico, ma informale, è un libro molto godibile, molto aperto anche a chi non frequenta la musica (per non dire la musica contemporanea)».
Come anche ricordi nella tua interessantissima prefazione al libro, la figura di Cage viene spesso ricordata più come quella di un pensatore che come quella di un vero e proprio compositore. Sembra da noi interessare più i filosofi che i musicologi insomma. Credi che questa circostanza sia dovuta – oltre alla evidente forza teorica e filosofica del suo pensiero – anche a un, più o meno inconscio, tentativo di “neutralizzare” (e quindi rendere innocuo collocandolo chiaramente in una sfera altra dalla “composizione” vera e propria) Cage da parte dell’establishment musicale europeo (e italiano in particolare) del Secondo Novecento?
«Certamente, e Cage ha fornito innumerevoli appigli a chi ha voluto evitare di parlare di che cosa è fatta la sua musica. Il suo pensiero, asistematico ma coerente, non smette di fornire spunti di riflessione ad artisti e studiosi e commentatori alla maggior parte dei quali poi, di fatto, non interessa il suo core business, la musica. D’altra parte le frequenti incursioni di Cage nelle arti visive, o nella letteratura sperimentale, persino nel cinema, sembrano dare ragione a chi vede in lui una figura di artista totale, in cui un pensiero astratto prevale sulla tecnica e sulla pratica artigianale. In realtà tutto quello che Cage ha fatto, anche di non musicale, è profondamente radicato in un modo di pensare che non potrebbe essere diverso da quello di un musicista. E aggiungo: europeo».
Puoi spiegare meglio quest’ultima affermazione?
«Cage giustamente concepisce se stesso come punto culminante di una "tradizione sperimentale" tutta americana, ma poi al fondo è davvero un discepolo radicale di Schoenberg, per il suo bisogno assoluto di soluzioni innovative ai problemi del comporre – quindi tutt’altro che indifferente alla sua stessa posizione nel divenire storico – che è anche un bisogno di rigore, di leggi, di sistema. Tra l’altro, a proposito di derivazione europea, basterebbe pensare a quanto Cage sia sempre stato indifferente se non ostile al jazz e ad altre tradizioni musicali americane».
«Cage è sempre stato chiaro: il caso è solo uno strumento per trovare risposte interessanti a delle domande su come mettere in atto un certo processo. Ma queste domande le pone, arbitrariamente, sovranamente, il compositore, e nessun altro»
È un fattore che solitamente colpisce molto chi ama sia Cage che le altre tradizioni americane... ma torniamo alla tentata neutralizzazione…
«Il tentativo di neutralizzare Cage, come dici, da parte dei compositori europei, soprattutto negli anni Cinquanta e Sessanta, è il prodotto di un’oscillazione continua di attrazione e repulsione. I Berio, Nono, Stockhausen, Maderna si affacciano sulla scena degli anni Cinquanta come innovatori radicali, e l’estremismo di Cage li affascina, ma in lui vedono un po’ il collega che in un certo senso si è bruciato le ali per aver volato troppo vicino alla fiamma, un po’ il colonizzatore americano (siamo in pieno dopoguerra). Ammirano il suo atteggiamento radicale, ma non riescono ad accettarne le conseguenze. Poi ci si mettono l’ultimo Adorno, e il suo discepolo Metzger, a vedere in Cage l’apostolo musicale della negazione determinata: una lettura dialettica e "politica" che è servita a cercare di districarsi nella crisi della composizione europea all’altezza degli anni Sessanta, ma che non ha reso un buon servizio a Cage e alla sua musica, di cui sono state enfatizzate le componenti più provocatorie e paradossali. C’è una specie di preistoria all’origine di questo pregiudizio, ed è scritta nella fitta corrispondenza che Cage e Boulez scambiano anni prima, tra il 1948 e il 1952 (è stata resa nota solo molti anni più tardi): ambedue sono interessati a un certo grado di spersonalizzazione della creazione artistica, a cercare la novità provando a mettere da parte la memoria e il gusto individuali. Per un po’ i loro intenti sembrano convergere, poi però quando Cage decide di usare il caso come arnese per comporre, anziché dei sistemi generativi più o meno automatici ma controllabili, per Boulez è troppo, non lo segue più. Diverso è il discorso per quelli appena più giovani, ancora in formazione: penso a Bussotti, Clementi, Donatoni, Kagel, Evangelisti, Cardew… che invece aderiscono con entusiasmo, ciascuno a modo suo. Ma anche per la maggior parte di questi Cage è più una macchina concettuale che non veramente un musicista. Eppure Cage è sempre stato chiaro: il caso è solo uno strumento per trovare risposte interessanti a delle domande su come mettere in atto un certo processo. Ma queste domande le pone, arbitrariamente, sovranamente, il compositore, e nessun altro».
Uno degli elementi umani che emerge dalle pagine di MusiCage è quello dell’ironia, qualità che in Cage era sorniona e destabilizzante (un esempio lampante è il celebre caso della performance al Lirico di Milano nel 1977) e che, abitualmente, sembra tratto poco frequente nella seriosità della musica contemporanea. Quanto l’ironia è elemento “utile” nell’affermazione di un’idea creativa (pensiamo alla forza delle idee di Nono, musicista assai poco ironico) e quanto invece risulta magari controproducente?
«L’ironia di Cage è uno dei tratti più evidenti della sua adesione allo Zen, inclusa la sua sostanziale disinvoltura nei confronti di un qualunque tipo di disciplina mistica. Nel suo sovversivismo Cage poteva essere terribilmente serio quanto comicamente assurdo. Vi sono varie fasi nel tempo, certamente il Cage quarantenne è quello che nei salotti fa buffi scherzi e scrive le sue opere più provocatorie. Poi c’è il vecchio saggio, ma capace di affondi ironici come quando presenta così le sue cinque Europeras: “L’Europa ci ha colonizzato con le sue opere liriche, ma adesso io le restituisco al mittente tutte insieme”. Ed è proprio così, un frullato vertiginoso di teatro musicale del Sette-Ottocento».
«L’ironia nella performance del Lirico di Milano era piuttosto implicita a una situazione parecchio improbabile, che fu costruita ad arte: Cage spacciato per un eroe dell’avanguardia in un senso imprecisato, genericamente politico (un po’ come la cantavano gli Skiantos in quegli anni, per intenderci), e poi gettato in pasto a 2000 ragazzi del tutto ignari di chi fosse e che cosa facesse, al punto che molti arrivarono a reclamare "il vero John Cage", cioè l’immagine del tutto fantastica che se n’erano fatti… Per quasi tre ore Cage reagì alle provocazioni del pubblico (in crescendo: petardi, gavettoni, invasioni di palco, girotondi, tentativi ravvicinati di sabotaggio) con il massimo della calma e dell’imperturbabilità. In realtà ebbe molta paura, questo lo confessò qualche tempo dopo, ma al momento lo mascherò molto bene».
Si suol dire che Cage sia presente – anche se in modo inconscio – in molta musica prodotta oggi. In che ambito pensi che questo sia più evidente?
«Cage ha cominciato fin dagli anni Trenta a usare sospensioni e freni di automobili come percussioni, ha desacralizzato il pianoforte, è stato il primo a usare sistematicamente apparecchi di riproduzione (radio, giradischi) come strumenti di produzione sonora, e infine ha sdoganato il potenziale musicale di qualunque fenomeno sonoro, anche accidentale (e i fin troppo famosi 4’33” di silenzio sono appunto questo), suggerendo che chi ascolta non deve ricevere un senso precostituito, ma lo deve costruire da sé a partire dalla propria esperienza. Qui sta il nocciolo della sua influenza permanente, oggi più ramificata che mai. L’elenco è lungo, e risalendo dalle tendenze più recenti, pensiamo alla soundscape composition oppure alle operazioni di data sonification dove la "musica" è generata a partire da sequenze di dati come quelli ricavati dal traffico di aerei, email, api, turisti a Venezia eccetera. Il tempo sospeso, non-narrativo e non-direzionale di una qualunque installazione sonora è sicuramente una conseguenza dell’estetica di Cage. Oppure, a livello strumentale, pensiamo a tutte quelle pratiche che fanno ricorso a strumenti impropri o modificati, dalla risposta non lineare. Il filone circuit bending / hardware hacking origina da lui, così come la pratica di amplificare eventi "microacustici" con microfoni a contatto. Quando poi si pensa alla collaborazione di Cage con la danza di Merce Cunningham, le dimensioni musicale e coreografica per principio non sono coordinate, ma chi assiste si troverà a costruire spontaneamente una relazione tra le due cose e quindi un senso: un modello per molte pratiche successive, magari meno radicali, ma comunque segnate da quest’idea di indipendenza dei due piani (musica e danza, o azione scenica, o immagine...)».
Dove invece le sue intuizioni sull’ascolto ti sembrano ancora poco recepite?
«Il concetto dell’ "ascolto profondo" sviluppato da Pauline Oliveros, per esempio: la disciplina cioè del non escludere alcun suono circostante dall’attenzione soggettiva come esercizio per una migliore comunicazione musicale all’interno di un gruppo. L’orizzonte di Cage, per quanto vasto, non comprendeva l’improvvisazione, ma nell’ultima parte della sua vita diceva di essere stato influenzato dalla musica di Oliveros, ossia da un’artista precedentemente influenzata da lui… Cage aveva anche questa umiltà».
Due lavori “classici” e due meno conosciuti (magari dell’ultimo periodo) di Cage che i lettori del "giornale della musica" dovrebbero conoscere e che hai voglia di segnalare loro?
«Tra centinaia di pezzi viene forte la tentazione di scegliere a caso, sarebbe perfettamente coerente col personaggio! Ma siccome Cage amava l’incoerenza, facciamo invece una scelta più o meno mirata. Chi conosce un po’ la sua storia sa che c’è un prima e un dopo la sua scoperta dell’I Ching (o Yijing), sia come testo, sia come metodo per la generazione di eventi casuali. Il manifesto della svolta è la Music of Changes, per pianoforte, del 1951, un titolo a senso multiplo che ricalca quello alternativo dell’I Ching, ossia Libro dei mutamenti. È una musica radicalmente diversa da tutta quella che precede, che disorienta l’ascoltatore, ed è il modello di tutto quanto Cage produrrà per i successivi quarant’anni. Nei quindici anni circa che precedono il 1951 c’è invece una musica molto formale, molto organizzata soprattutto dal punto di vista ritmico, dove comunque spunta sempre il caso, se si pensa agli effetti relativamente imprevedibili e variabili dell’inserzione di oggetti tra le corde del pianoforte "preparato". Se vuoi dei "classici" io sceglierei del periodo pre-51 la First Construction (in Metal) del 1939, capostipite di una serie di pezzi che Cage scrisse negli anni Quaranta per la sua "band" di percussioni. Consiglio questa esecuzione dei magnifici ungheresi di Amadinda, sotto la supervisione dello stesso Cage».
«E poi Aria insieme a Fontana Mix, i due pezzi "milanesi" di Cage, scritto l’uno per Cathy Berberian (1959), l’altro composto qualche mese prima allo Studio di Fonologia della RAI. Possono essere eseguiti insieme o separatamente. Ovviamente lo ascoltiamo nella storica esecuzione di Berberian».
«Se invece mi chiedi due pezzi meno conosciuti segnalerei senz’altro il Concerto per pianoforte preparato e orchestra da camera. Scritto tra il 1950 e il 1951, è in tre movimenti di cui l’ultimo è anche il primo pezzo in assoluto in cui Cage compone per mezzo del caso. È veramente sul crinale tra determinato e indeterminato, c’è dentro il Cage del prima e del poi, ed è un bellissimo pezzo di musica, pieno di sorprese e di invenzioni sonore. L’orchestra comprende strumenti normali ma anche una radio, una molla d’acciaio amplificata e altri oggetti di trovarobato. Mi piace molto questa versione dal vivo con John Tilbury, uno storico interprete dei musicisti della cosiddetta New York School».
«Molto belli i tanti pezzi dell’ultimo periodo, quando Cage disse di avere tardivamente riscoperto l’armonia – naturalmente un’armonia "anarchica". Hanno quasi tutti per titolo il numero degli esecutori. Scelgo uno dei più grandiosi e suggestivi, 103, evidentemente per grande orchestra ("anarchica", il direttore qui non serve), una delle sue ultimissime cose. Insieme a 103 si può vedere One11, un film muto che Cage ha composto a partire da operazioni casuali condotte sull’uso degli obiettivi e delle luci, ma senza alcuna immagine vera e propria. Il tutto dura un’ora e mezza, va benissimo ascoltarlo con attenzione fluttuante… e comunque Cage aveva un senso infallibile su quanto dovesse durare un processo musicale in rapporto al materiale impiegato».