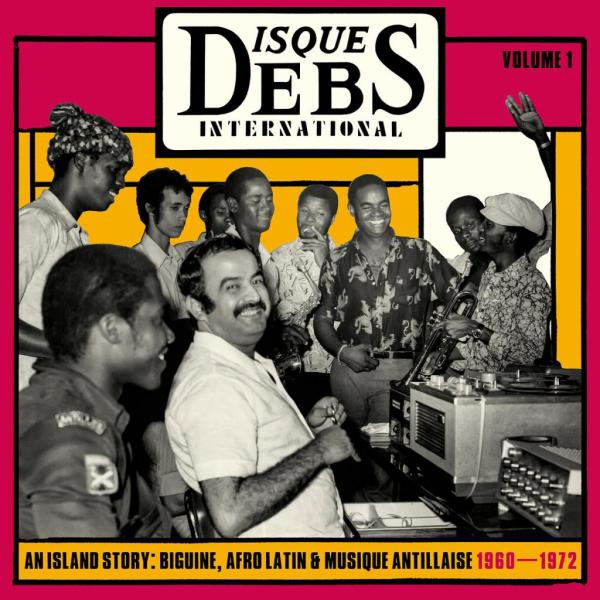Il rischio è quello della balcanizzazione. E non ci stiamo riferendo alle turbolenze politiche, religiose e militari che in effetti hanno una serie di tragiche similitudini che potrebbero far accostare i Balcani degli anni Novanta e la fascia sahariana degli ultimi dieci anni. Ci stiamo piuttosto riferendo all’improvvisa, e imponente, produzione discografica che segue un vero e proprio afflato di innamoramento da parte del pubblico occidentale per un genere e una scena musicale di cui si conosceva poco o nulla prima di un’esplosione fragorosa e improvvisa…
Ecco, così come negli anni Novanta le colonne sonore di Bregovic e le prime esibizioni delle bande di ottoni hanno provocato dapprima un poderoso fluire di produzioni e poi, alla lunga, una sorta di “rigetto” da iperesposizione,tanto che negli ultimi anni i combo di matrice balcanica fanno sempre più fatica a collocarsi nei festival perché appena qualcuno qualcuno li propone qualcun altro risponde: “non se ne può più!”. Non vorremmo che questa dinamica coinvolgesse anche i dischi di musica tuareg…
All’inizio degli anni duemila il Festival au Desèrt che si teneva poco a nord di Tombouctou, in Mali, ha lanciato i primi gruppi dediti a una versione elettrificata della musica tuareg, cantata in tamashek e suonata con bidoni vuoti per la benzina, imzad (liuto a una corda), battito di mani, chitarre elettriche e qualche voce. Tra questi gruppi il più rappresentativo e il primo a esplodere anche nel mercato globale fu il combo dei Tinariwen. Ma da lì a poco (proprio come nel caso della musica balcanica) cominciarono a fiorire figli e figliocci, parenti vicini e lontani, una serie di gruppi e sottogruppi più o meno legati al ceppo originario dei Tinariwen. La lista è lunga: Tamikrest, Tartit, Bombino, Kel Assouf, Terakaft, Athman e Nabil Bali, Atri N’Assouf, Rissa Ag Wanaghli, Toumast, Amanar, Etran Finatwa, Timmidwa, Amanar… solo per citarne alcuni.
In alcuni casi (Tamikrest, Bombino, Tartit ad esempio) la proposta veicolata ha aggiunto colori nuovi alla tavolozza di questa tradizione sonora, contribuendo in maniera decisiva a rendere più frastagliato e denso l’intero bacino. In altri casi, le copie, delle copie, delle copie hanno finito solo per saturare il mercato innescando forse una prima forma di latente “rigetto” tra gli astanti. Sia come sia, l’evoluzione di questo meccanismo che è in parte culturale e in parte commerciale la vedremo e soppeseremo tra qualche tempo.
In questo caso parliamo di due uscite discografiche importanti, perché accreditate a due gruppi leader della scena. Combo che sono capofila del nuovo movimento musicale tuareg: i Tinariwen appunto, e i Tamikrest. Entrambi escono con due nuove produzioni in queste settimane, entrambi vengono licenziati da etichette molto rappresentative della scena indie: la californiana Anti e la tedesca Glitterbeat.
L’inconfondibile chitarra elettrica suonata senza plettro da Ibrahim Ag Alhabib, chitarra e voce della band, apre anche il percorso di Elwan, il nuovo album dei Tinariwen, registrato tra il Joshua Tree e il Marocco. Sono stati i primi ad affermarsi, ma continuano ad evolversi e questo disco licenziato dopo una lunga serie di uscite ben accolte e ben veicolate lo dimostra senza tentennamenti. Il loro suono resta scarno, gli strumenti utilizzati pochi, le melodie iterative, ma gli arrangiamenti dei dodici brani hanno quasi sempre un piccolo colpo di coda, che li toglie dall’anonimato e dal mainstream di genere.
Vecchie volpi del folk-rock statunitense ci mettono il loro illuminato zampino: Matt Sweeny (al lavoro con Johnny Cash, Bonnie Prince Billly, Cat Power), Alan Johannes (produttore di alcuni lavori dei Queen Of The Stone Age), e soprattutto Mark Lanegan e Kurt Vile (con il quale i Tinariwen hanno già lavorato alla meravigliosa “Wheelhouse“). Cosicchè quando iniziano “Ittus”, “Talyat”, “Arhegh Ad Annàgh” e “Nànnuflày”, con le loro intro di chitarra dopate dal caldo, non si riesce bene a capire se ci si trova nel deserto del Mojave o in quello del Sahara, mentre la conclusiva “Fog Edaghàn” con il suo refrain tribale, riporta tutta la crew e senza tema di smentite nelle dune a Nord del Mali, in quel territorio flagellato dai conflitti degli ultimi anni, ma considerato da sempre “casa” dai Tinariwen.
Tra i posti che tutti i tuareg del Mali considerano casa, c’è sicuramente la città e la regione di Kidal. Situata in un imbuto di sabbia che poggia il suo confine anche su Algeria e Niger, Kidal è anche il titolo dell’ultimo album dei Tamikrest. Da sempre considerati la frangia più rock e più giovane del movimento desert blues, i Tamikrest si sono formati nel 2006. Un gruppo di ragazzi poco più che ventenni che hanno messo spesso il turbo alle distorsioni e alle ritmiche delle loro canzoni. Capita anche in questa nuova uscita, registrata a Bamako, in Mali, e prodotta da Mark Mulholland (Tony Allen’s Afro-Haitian Experimental Orchestra). Pur contando sugli interventi del francese Paul Salvagnac alla chitarra e utilizzando strumenti come lo ngoni (tipico dell’etnie del centro-sud del mali, non esattamente uno strumento tuareg), la tavolozza timbrica di questo album copre un range meno esteso di quello dei Tinariwen.
«Tutte le canzoni parlano di deserto e di dignità» – dice il leader dei Tamikrest Ousmane Ag Mossa, e segnala non solo il patronato dispotico del governo centrale di Bamako nei confronti dei territori del Nord, ma anche il vizietto dei governanti delle ex colonie di continuare a pensare alla terra dei tuareg come ancora loro. “Wainan Adobat”, il primo singolo e video tratto dalla tracklist dell’album, chiarisce bene i termini del progetto sonoro. Batteria ben in vista (laddove i Tinariwen spesso adottano percussioni), cassa potente, basso a cinque corde, riff di chitarra acidula che sfocia in un call and response con le voci sulla stessa melodia…
Nel finale del video di questo brano un pick up con a bordo Ousmane sfila via nel tramonto delle sabbia intorno a Kidal; poco prima un gruppo di bimbi aveva posato intorno al cartello di entrata della città e gli altri componenti della band avevano preparato un tè alla maniera tradizionale in uno studio di registrazione stipato di strumenti e mixer…. la vecchia e la nuova africa, il vecchio e il nuovo deserto, i vecchi e i nuovi tuareg…